Strada Pelosa Canale Brentella Il LazzarettoLa Guerra Chiesa di Cave |
Il Lazzaretto alle Brentelle
Il lazzaretto alle Brentelle fa parte della lunga lista dei monumenti demoliti a Padova nei primi decenni del XIX secolo, all'indomani della radicale trasformazione politico-amministrativa subentrata al crollo del regime napoleonico...
Le note che seguono sono state liberamente tratte dal bellissimo libro:
Il Quartiere Brentella: la Città di Padova oltre le mura occidentali a cura di Claudio Grandis.
Una breve premessa
Costruito tra il 1533 e il 1555 il Lazzaretto venne eretto nello stretto spazio racchiuso tra la riva destra del canale Brentella e l'antico "Arzeron comune", oggi Via Montecero.
Della sua presenza ci sono rimaste solo poche immagini, il nome di un corso d'acqua - il Lazzaretto (1) per l'appunto - e l'edicola religiosa posta all' incrocio di Via Pelosa con Strada VII Martiri, contenente un' antica statua raffigurante S.Rocco,(FOTO INAUGURAZIONE) il patrono cui ricorrevano le popolazioni di mezza Europa tutte le volte che si manifestavano sintomi di epidemie e pestilenze. l'edicola religiosa posta all' incrocio di Via Pelosa con Strada VII Martiri, contenente un' antica statua raffigurante S.Rocco,(FOTO INAUGURAZIONE) il patrono cui ricorrevano le popolazioni di mezza Europa tutte le volte che si manifestavano sintomi di epidemie e pestilenze.
(1) Lo scolo Lazzaretto corre lungo il lato ovest di Via Montecero, proveniente dall'abitato di Caselle e precisamente dalla chiavica regolatrice di Treponti; termina il suo percorso nel grande di bacino di raccolta dell'idrovoradel Brentella, scavato dopo l'alluvione del 1966.
Le vicende politiche
Tra il 1523 e il 1533 il Consiglio della città di Padova dibattè a lungo sulla necessità di costruire un nuovo lazzaretto visto che il precedente, ricavato nel piccolo monastero femminile di Fistomba, era stato abbattuto per creare la spianata attorno alle nuove mura della città.
Padova era stata riconquistata da Venezia sul finire del 1509. Tra gli immediati provvedimenti del Senato Veneto, rientrava, tra l'altro, la costruzione delle nuove mura difensive ...  La costruzione delle mura, in particolare, comportò una profonda alterazione dell'immediata periferia della città. Essa infatti interessò, non solo gli spazi per l'elevazione delle murature, degli spalti e dello scavo dei fossati, ma coinvolse pure l'immediato anello esterno per un'estensione di oltre 1.500 metri dalle mura verso il contado, che venne sistematicamente sgombrato da ogni presenza (spianata che assunse il nome di Guasto). La costruzione delle mura, in particolare, comportò una profonda alterazione dell'immediata periferia della città. Essa infatti interessò, non solo gli spazi per l'elevazione delle murature, degli spalti e dello scavo dei fossati, ma coinvolse pure l'immediato anello esterno per un'estensione di oltre 1.500 metri dalle mura verso il contado, che venne sistematicamente sgombrato da ogni presenza (spianata che assunse il nome di Guasto).
Erano stati i progettisti militari ad imporre la realizzazione della spianata ...le nuove tecniche militari elaborate con l'avvento delle potenti macchine da fuoco prevedevano che, per colpire i potenziali assedianti, lo spazio doveva essere sgombro da ogni riparo.
Tra gli edifici abbattuti figurava anche il vecchio lazzaretto, o "Nazareth", ricavato all'interno del monastero delle monache benedettine di Fistomba, in seguito al trasferimento delle religiose nel convento cittadino di S.Stefano (l'odierno palazzo della Prefettura).
La scelta dell'area: le ragioni logistiche
In epoca carrarese (1318-1405) ... si era convinti che il contagio provenisse dalla nemica
Venezia, città rivale, ma anche scalo privilegiato delle
merci provenienti dall' Oriente.
All'indomani della conquista di Padova
questa convinzione venne meno. Da Venezia, tenuto conto dei controlli
su passeggeri e merci, non c'era più motivo di temere il
diffondersi di epidemie.
Altrettanto non si poteva dire per ciò
che arrivava dal Trentino e dalla Lombardia. Dalla zona occidentale
e settentrionale gran parte dei viaggiatori e delle merci giungevano
a Padova per mezzo di imbarcazioni e zattere, passando necessariamente
per il canale Brentella e per il vicino centro del Bassanello. Collocare
in questa zona un posto di controllo, avrebbe facilitato le operazioni
e l'eventuale deposito per quaranta giorni (la nota quarantena)
delle persone e delle merci stesse.
L'ubicazione del Lazzaretto in questa
zona consentiva pure di convogliare eventuali persone e merci infette
provenienti dalle strade, come la "Mestrina"
(odierna Statale 11), la "Montanara" (attuale Strada dei
Colli) e la "Strada Battaglia" (odierna Statale 10); seppure
praticabili solo nelle stagioni favorevoli, le antiche piste in
terra battuta convogliavano in città considerevoli quantitativi
di merci e persone a piedi, a cavallo e in carrozza.
La corte benedettina di Praglia
Seppur resta incerta la data del trasferimento,
è comunque sicuro che già nel 1527 il Lazzaretto era stato provvisoriamente trasferito a Brusegana
presso l'antica corte benedettina del monastero di Praglia (l'odierno
Istituto Tecnico Agrario "Duca degli Abruzzi" - nella foto).
L'11 febbraio di quell'anno il Doge
di Venezia Andrea Gritti ordinava
al podestà ed al capitano di Padova di provvedere affinché
gli ammalati fossero trasportati in altro luogo e che si trovasse
un'area idonea da destinare stabilmente a lazzaretto .. ordini ed
inviti a restituire la corte benedettina ai monaci furono reiterati
dal Doge, fino al 1533 quando il Consiglio della città raggiunse
l'accordo per l'acquisto del terreno e diede l'avvio ai lavori in
località Barca "loco alla Stra Pelosa sopra l'acqua
delle Brentelle tra il ponte di Brentelle de Sopra e quello de Sotto
miglia doi distanti de quella cità".
La costruzione del Lazzaretto nuovo
a) L'acquisto dell'area
Tra le prime attestazioni
di volontà dirette alla costruzione del nuovo lazzaretto,
troviamo una ducale (tipico provvedimento del Doge veneziano)
del 1523 con il quale si autorizzava il riuso di pietre, coppi e
legnami provenienti dalla demolizione di alcune case abbattute in
"curia palatii" (odierna Piazza Capitaniato) per la costruzione
del nuovo Lazzaretto;
Da questa data e fino al 1533, anno d'inizio
dei lavori, è un susseguirsi di provvedimenti, deliberazioni
cittadine e ducali del Doge veneziano. Il ritardo di
circa dieci anni tra la decisione iniziale e l'avvio dei lavori è da imputarsi alla contrastata vicenda
che interessò l'acquisto del terreno... l'avvio dei lavori è da imputarsi alla contrastata vicenda
che interessò l'acquisto del terreno...
Nel 1529 la Comunità di Padova
acquistò i terreni appartenuti a Brunoro da Thiene. In realtà
quella prima scelta non fu ritenuta la migliore poiché l'area
risultava troppo bassa e soggetta agli allagamenti del canale Brentella.
La decisione iniziale si spostò dai terreni della famiglia
Thiene, posti in capo alla strada Pelosa, a quelli più interni,
ma contigui ai primi, di proprietà dei Camposanpiero, antica
e nota famiglia cittadina. Alla fine vennero acquistati entrambi
gli appezzamenti di terreno racchiusi dal Brentella ad est, dalla
strada Pelosa a nord e dalla strada vicinale (oggi Via Montecero)
a ovest per complessivi dodici campi padovani (pari a 47.800 mq.)
b) La progettazione della fabbrica
Erice Rigoni, sulla scorta del
"Giornale di cassa del 1533-43" sostiene che
i lavori, iniziati nell'agosto del 1533 e ancora in corso nel 1543,
si conclusero in data imprecisata. Una conferma di tale stato di
cose viene dalla decisione presa dal Senato veneto nel 1545, per
agevolare il prosieguo del cantiere, di autorizzare il riuso di
materiali provenienti dal crollo del castello di Limena.
Come per molte altre costruzioni del
XVI secolo anche il Lazzaretto conserva gelosamente l'ignota paternità
del suo progettista.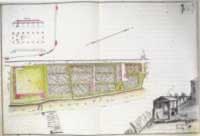
Tra il 1532-33 a Padova sono
presenti diversi nomi celebri dell'architettura veneta. Dal 1929
opera a Venezia e in terraferma Sebastiano Serlio; nel 1532 Giovanni
Maria Falconetto è alle prese con il Monte di Pietà
in Piazza Duomo; dal 1530 Michele Sanmicheli fa la spola tra la
laguna e Verona, progettista del Palazzo Canossa a Verona (1531-1537).
Nel 1532 arriva a Padova pure Andrea Moroni da Albino (Bergamo),
il progettista della chiesa di S.Giustina, dell'ala antica del
palazzo comunale (oggi Palazzo Moroni), del cortile antico del
Bo e dell'Orto Botanico. Pochi anni dopo il suo arrivo in città,
e sicuramente dal 1539, il Moroni riceve l'incarico di ripensare
e progettare le più importanti fabbriche pubbliche delle
città, tra le quali, probabilmente, anche il Lazzaretto
alle Brentelle. |
c)Il cantiere
La fonte esclusiva,
sull'andamento del cantiere è "il Giornale di
cassa" che, oltre a riportare i quitidiani pagamenti
per la fornitura dei materiali e l'esecuzione dei lavori, ci presenta
un animato mondo di artigiani e commercianti. L'impresario
edile è un certo Giacomo da Lona (località del Trentino
da sempre nota per essere una delle principali sedi estrattive
e lavorative della pietra di porfido); l'incarico deriva dal contratto
sottoscritto il 4 Agosto 1533 nel quale appaiono elencati i prezzi  unitari a misura di murature, volti, crociere, camini, sia le
modalità di calcolo dei volumi e delle opere. Fornitore degli inerti per gli
impasti cementizi e per la posa dei materiali lapidei (trachite,
pietra di Costozza e di Nanto) è Bartolomeo Pomaran il
quale sottoscrive un accordo che prevede la consegna dei materiali
a piè d'opera e l'unità di misura - la burchiela (barca) - per le quantità recapitate. Altri contratti
si concludono con il tagliapietra Bartolomeo, il falegname Onorio
e il fornaciaio Francesco della Sega, mentre a Battista Tessaro
è affidata la fornitura della calcina. unitari a misura di murature, volti, crociere, camini, sia le
modalità di calcolo dei volumi e delle opere. Fornitore degli inerti per gli
impasti cementizi e per la posa dei materiali lapidei (trachite,
pietra di Costozza e di Nanto) è Bartolomeo Pomaran il
quale sottoscrive un accordo che prevede la consegna dei materiali
a piè d'opera e l'unità di misura - la burchiela (barca) - per le quantità recapitate. Altri contratti
si concludono con il tagliapietra Bartolomeo, il falegname Onorio
e il fornaciaio Francesco della Sega, mentre a Battista Tessaro
è affidata la fornitura della calcina.
Dopo alcuni stati
di avanzamento (1534-1535-1537) a cura del perito Giovanni Domenico
Dall'Abaco, il "Giornale di cassa" si chiude
il 5 Aprile del 1543 a riprova che il primo stralcio dei lavori
doveva intendersi o compiuto nel rispetto del progetto iniziale
o concluso per mancanza di fondi o, ancora, sospeso per inadempienze
contrattuali mosse alle imprese appaltatrici.
Fa propendere per quest'ultima
ipotesi il fatto he l'incarico di stimare i lavori non sia più
affidato al Dall'Abaco (attivo a Padova fin oltre il 1559) ma
ad una terna (arbitrale?) di tecnici, eletti dai provveditori
al Lazzaretto, formalmente costituita con un rogito del notaio
Giovanni Maria Mazzocco, che sottoscrive l'atto nelle vesti di
cancelliere della Comunità di Padova. La sottoscrizione
di cancelliere, infatti, ci riporta ad un incarico solitamente
ricoperto nell'ambito degli uffici giudiziari del tempo; il che
indicherebbe l'esistenza di un contenzioso o di una lite sorta
sulla qualità o sulle modalità esecutive dell'opera,
rimessa alla superiore autorità.
d) la struttura
architettonica
Il Lazzaretto si presentava
nelle forme di un grande chiostro a pianta rettangolare ripartito
su quattro lati, di cui due e mezzo edificati e porticati, ove
in una sequenza modulare trovavano posto 70 stanze, e i restanti
uno e mezzo definiti da alte mura. Le stanze misuravano quattro
metri per cinque ed erano dotati di due finestre verso l'esterno.
L'ala lungo il canale, rivolta a levante, si presentava a due
piani con soprastante granaio, nonché dotata, verso l'interno,
di un loggiato sovrapposto al portico.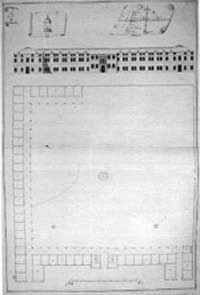
Al centro del cortile, visibile
da tutte le stanze, stava un tempietto aperto su tutti i lati
ove un colonnato, eretto ai vertici della base ottogonale, sorreggeva
la cupola che proteggeva l'altare con la statua di S.Rocco, il
santo patrono invocato dagli appestati per ottenere la guarigione.
Nel suo insieme il complesso misurava
all'esterno circa 97 metri per 103 ed era contiguo a nord con
il cimitero comune, la grande tettoia riservata al trattamento
e distruzione delle merci infette e, infine, con un'area posta
a ridosso della strada Pelosa, ove sorgevano le casette delle
maestranze e su cui svettava una massiccia torre colombara.
Il concetto sanitario ispiratore
dei questa architettura si fondava sulla divisione delle sezioni
di ricovero delle persone colpite da malattia da quelle poste
in osservazione (quarantena) e sulla presenza di ampie finestrature
in grado di assicurare una continua ventilazione; i diversi corpi,
infine, risultavano così collegati e disimpegnati tra loro
solo attraverso spazi aperti porticati.
L'organizzazione e la gestione del Lazzaretto
Già prima della costruzione il
Lazzaretto venne dotato di un cospicuo complesso di beni fondiari
e di rendite, in grado di assicurare un cespite per pagare le
spese di amministrazione. Tra queste figuravano le rendite di
tre ospedali della città; a queste si aggiungevano le rendite
"nette", cioè una tassa fissa di due bagattini per ogni pegno acceso al Monte di Pietà e, per un
breve periodo, si aggiunsero gli utili riscossi al "passo
volante" del Bassanello, un traghetto sul Bacchiglione
appositamente istituito per facilitare il transito di persone e
merci da una riva all'altra del fiume.
L'Ufficio di Sanità doveva provvedere
alla gestione tecnico-amministrativa del complesso paraospedaliero.
Nei locali della struttura sanitaria erano ricoverati "innumerevoli
schiere di poveri"... chi veniva rinchiuso non poteva
uscire senza apposita autorizzazione. A vigilare sia
sulle persone che sulle cose vi erano all'esterno ed all'interno
guardie armate, con l'ordine di sparare contro chiunque tentasse
di fuggire o di asportare le merci poste sotto osservazione.
Note di cronaca in margine alla vita del lazzaretto
Durante l'età
veneziana, Padova fu colpita da numerose epidemie e pestilenze.
Le più note restano quelle del 1575 e del 1629-31, ma
epidemie di vario genere furono frequenti e continue. Nei periodi
sospetti merci e persone non potevano spostarsi senza la "fede
di sanità"... chi veniva fermato privo del
documento finiva immediatamente in carcere. L'esempio che segue
illustra questa condizione.
Nel 1555, anno di peste, il rapimento
della dodicenne Lucrezia Bonamico, figlia ormai orfana del celebre
professore universitario Lazzaro, fu involontariamente sventato
proprio da un posto di blocco istituito dall'Ufficio di Sanità
al passo di Curtarolo sul Brenta. I tre sequestratori avevano
rapito Lucrezia a scopo di matrimonio, senza munirsi dell'apposito
lasciapassre sanitario. Bloccati ed arrestati dalla sbiraglia
del podestà Pietro Morosini, vennero ricondotti a Padova
ed imprigionati. Dopo qualche giorno, i tre sequestratori, condannati
a morte, vennero decapitati sulla pubblica piazza, con grande
sbigottimento della città, a cui tanta severità
parve eccessiva, visto che il matrimonio non era stato consumato.
La fine del Lazzaretto
La fine del Lazzaretto
venne decretata dalla costruzione del nuovo ospedale Giustinianeo,
iniziata nel 1775. Persa l'originaria funzione di luogo d'isolamento
e di segregazione per appestati o presunti tali, il "magnifico
ed insigne" edificio che girava attorno all'ampia piazza
dominata dalla chiesetta di S.Rocco, venne totalmente abbattuto.
Con la soppressione dell'Ufficio di Sanità,
decretata nel 1810 dopo 'istituzione della Congregazione di
Carità (1807), l'area e i terreni adiacenti passarono
nel patrimonio disponibile del comune di Padova che il 14 agosto
1821 ne decretò la vendita all'asta. Nel 1826 erano ancora
pendenti i rapporti tra comune ed acquirente, per sopravvenute
difficoltà di quest'ultimo nell'assolvere l'impegno assunto;
tuttavia, poco tempo dopo, ogni traccia del secolare monumento
era definitivamente cancellata . .
Non completemente cancellata ne
è invece la memoria...il ricco fondo archivistico dell'Ufficio
di Sanità che contiene una ingente mole di documenti
sulla gestione, la vita e l'attività del Lazzaretto;
le diverse mappe che ne riproducono l'aspetto architettonico;
la toponomastiva locale che ancora attribuisce a uno scolo
l'idronimo Lazzaretto; la devozione a S.Rocco, ripresa nel 1990
dopo alcuni decenni di abbandono (Festa il 16 di Agosto nella golena del Brentella).
Ma il monumento più rilevante
resta quell'appezzamento di terreno utilizzato come fossa comune
per dare dignitosa sepoltura alle migliaia di appestati morti
tra le mura del lazzaretto: ancor oggi si attende che qualcuno
lo protegga e ne ricordi la triste funzione; sotto quella terra
riposano le reliquie di tanti nostri antenati. |











